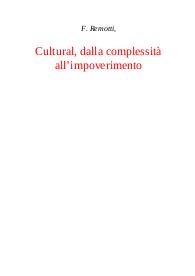
Esistono due concezioni fondamentalmente diverse di cultura: una classica e tradizionale che afferma e propone un ideale di formazione individuale; è una concezione di tipo prescrittivo e normativo e indica un dover essere per alcuni individui di alcune società. La seconda è moderna e scientifica, è stata fatta valere dalle moderne scienze sociali ed è di tipo analitico e descrittivo, illustra una condizione che riguarda i membri di qualsiasi gruppo sociale. Entrambe, però, si fondano su una metafora agricola: cultura, deriva infatti dal verbo latino “colere” che significa principalmente abitare, coltivare, ornare, venerare, esercitare. Emergono due elementi: da un lato la cultura separa aristocraticamente l’individuo che si sottopone al suo esercizio dal popolo incolto e lo sottrae ai costumi della sua particolare società; dall’altro questa stessa cultura immette l’individuo in una società diversa da quella locale. La cultura intesa in senso classico, si rivela quindi incomparabile con i costumi e per questo si combina all’idea di una società astratta e liberata dai condizionamenti locali e temporali. La differenza essenziale tra concezione classica e quella moderna di cultura è data dall’assenza o dalla presenza dei costumi come contenuti della cultura. La cultura in senso classico era costituita da ideali, verità e valori no condizionati dai mores (costumi); la cultura in senso moderno è costituita dai costumi che si rivelano importanti in molti ambiti del comportamento umano. Tra il 1768 e il 1780 avvengono le tre spedizioni nel Pacifico meridionale di James Cook e tra i pensatori della seconda metà del secolo, la figura di maggiore spicco è quella di Johann Gottfried Herder. Tipico di Herder è il rifiuto della troppa filosofia: alla base di questi atteggiamenti c’è la percezione della pluralità delle forme di vita che l’umanità può assumere e quindi l’improponibilità della cultura in senso classico. Emerge ben presto il concetto di “cultura dell’umanità” il quale si configurava come alternativo e contrastante rispetto al concetto di cultura della ragione o dello spirito. Vediamo quindi emergere questo concetto etnografico di cultura, che verrà poi fatto proprio dagli sviluppi delle scienze sociali. Questo concetto assume un ruolo determinante nell’etnografo Gustav Klemm secondo cui la cultura costituisce “ciò che vi è di essenziale nella storia”. L’inglese Edward B. Tylor aggiunse una definizione più esplicita e sintetica rispetto a Klemm: “La cultura è quell’insieme complesso che include la conoscenza, le credenze, l’arte, la morale, il diritto, il costume e qualsiasi altra capacità e abitudine acquisita dall’uomo come membro di una società”. In questa definizione si possono notare l’imprescindibilità della dimensione etnografica, l’idea che la cultura sia un’insieme che ingloba diverse attività, il carattere acquisito di questo insieme e la connessione del concetto di cultura con quello di società, nel senso che l’acquisizione della cultura avviene per il fatto di far parte di un gruppo sociale.
 storia del commercio
storia del commercio